Le nostre Fonti
Trattati storici e maestri di scherma medievale
e rinascimentale di riferimento

Royal Armouries Ms. I.33.
01. Contesto Storico
Si tratta del più antico trattato di scherma a noi pervenuto e uno dei più antichi al mondo. Sembra sia stato scritto dal monaco Lutegerius, possibile latinizzazione di Liutger. Il punto è che poco si sa dell'autore e tra le diverse ipotesi c'è quella secondo la quale si tratterebbe di un cavaliere ritiratosi in monastero.
02. Il Trattato
Il trattato, mutilo di alcuni fogli, si occupa dell'arte del combattimento con spada medievale e brocchiere, attraverso un sistema di guardie (custodie) e controguardie o assedi (obsessiones). Di tecnica in tecnica il monaco vuole mostrare al proprio allievo le differenze tra l'uso comune di queste armi e i saggi consigli che invece lui stesso è in grado di fornire. Il fechtbuch (manuale di combattimento) sembra provenire dall'area della Franconia.
Flos duellatorum in armis, sine armis, equester et pedester
01. Contesto Storico
Il più antico trattato italiano giunto sino a noi e databile al primo decennio del XV secolo. Di quest'opera esistono in realtà almeno quattro diversi manoscritti, conservati in Francia e negli Stati Uniti, mentre la versione presente in Italia è conservata solo in fac-simile, essendosi perduto l'originale ad inizio Novecento.
02. Il Trattato
Il trattato è particolarmente ricco e si configura come un completo vademecum per l'uomo d'arme del tempo, contemplando sia il combattimento in armatura che non, tanto a piedi quanto a cavallo. Vi si trovano infatti tecniche di spada a due mani, di daga, lancia, azza, bastone e lotta. L'autore, Fiore de' Liberi di Premariacco, friulano, nell'introduzione all'opera ci dice di aver imparato la sua arte da numerosi maestri, anche tedeschi, e di aver combattuto e fatto pratica per oltre quaranta anni prima di scrivere il suo trattato. La scherma di Fiore è potente, risolutiva, decisamente adatta al campo di battaglia. Si tratta probabilmente di uno degli autori che hanno avuto più influenza al tempo e sicuramente uno dei più studiati dai praticanti moderni. Grazie al confronto tra i quattro manoscritti conosciuti oggi l'opera di Fiore presenta meno lati oscuri rispetto al passato, ma nonostante ciò è in grado di regalare ancora nuove emozioni e nuove scoperte allo studioso attento.
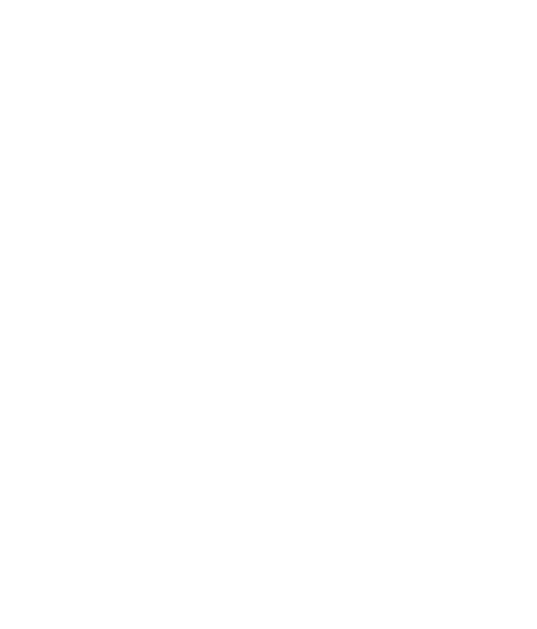
“Fate li fatti che parole non hanno loco. ”
Fiore de Liberi

De Arte Gladiatoria Dimicandi
01. Contesto Storico
L'opera di Vadi è collocabile tra il 1482 e il 1487 e risente fortemente dell'influenza di Fiore de'Liberi. Come aveva fatto quest'ultimo settanta anni prima, anche Vadi sottolinea la propria esperienza sul campo e afferma che le tecniche proposte sono state da lui sperimentate. Il mestiere e la conoscenza delle armi si acquisivano principalmente con la prassi bellica, un segno di garanzia che il maestro pisano non esita a ribadire.
02. Il Trattato
Il trattato presenta un'interessante parte testuale in cui si riportano diverse concezioni tardo quattrocentesche inerenti i principi fondamentali dell'arte del combattimento e numerosi consigli per l'umo d'arme. Vadi si occupa di spada a due mani, daga, lancia e combattimento in armatura. A parte alcune singolarità, traspaiono sia collegamenti con la tradizione italiana successiva che con una scherma di spada a due mani con posizioni più chiuse e probabilmente volte od ottimizzarne la funzionalità nel combattimento "sine armis".
Tradizione Tedesca (Molteplici Fonti)
01. Contesto Storico
La tradizione marziale di area germanica è certamente una delle risorse principali per lo studio della spada a due mani nel Medioevo: l’uso di quest’arma è ivi ampiamente diffuso, soprattutto nell’ambito del duello, e si riscontrano tracce dell’esistenza di diverse correnti, talvolta scuole, che se ne sono interessate. La scherma medievale tedesca ha lasciato infatti molteplici testimonianze, sia iconografiche che testuali: decine di manoscritti, nomi dei maestri, delle confraternite, addirittura specializzazioni degli autori in specifiche discipline (spada a due mani, messer, lotta, brocchiero ecc.).
02. Il Trattato
n questo vastissimo mare documentario, ci siamo concentrati sulla prima parte della tradizione di Johannes Liechtenauer, maestro vissuto tra XIV e XV secolo nel cuore del Sacro Romano Impero, autore dello Zedel, ossia componimento criptico che custodisce i segreti dell’Arte della scherma. Al suo insegnamento fanno riferimento i maestri della cosiddetta Geselschaft Liechtenauers, confraternita di Liechtenauer appunto: grazie agli scritti di questi ultimi, gli studiosi moderni sono riusciti a ricostruire il sistema e gli insegnamenti del Maestro. Gli scritti dell’anonimo del Codex Danzig, di Andre Liegniczer, di Sigmund Ringeck e di Jud Lew sono alcuni tra quelli da noi utilizzati per approfondire e riportare in vita questa importantissima parte dell’arte marziale europea, sia per la spada a due mani che per altre armi, come il messer e la daga. Tra i nostri riferimenti non può mancare anche il maestro Hans Talhoffer, di metà XV secolo, il cui insegnamento è riportato ad esempio nel MS Thott.290.2º-1459- e nel Cod.icon. 394a - 1467).
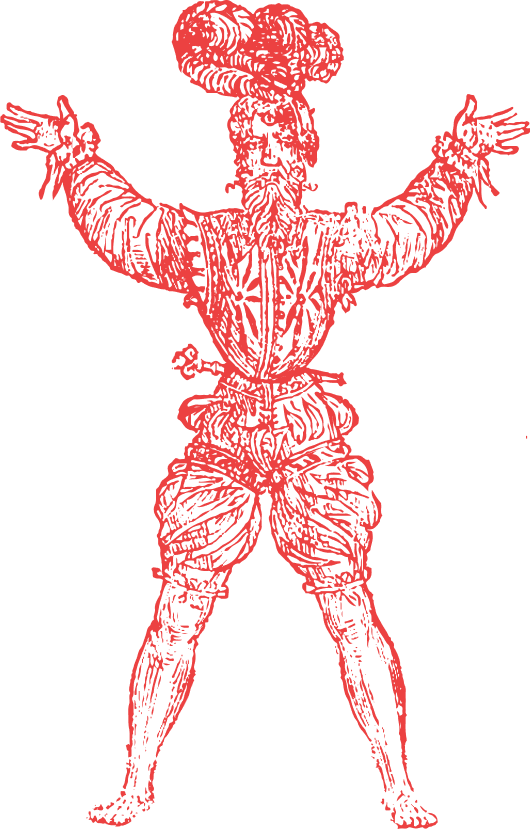
Tradizione Rinascimentale Italiana (Molteplici Fonti)
01. Contesto Storico
La tradizione marziale e schermistica della penisola italiana mostra tutta la sua complessità e grandezza nel XVI secolo, con lo sviluppo del duello d'onore e la pubblicazione di molti trattati sull'Arte delle armi. Alcune di queste opere raggiunsero in breve fama internazionale, portando a traduzioni in altre lingue.
02. Il Trattato
Il grado di complessità, la varietà, la profondità tattico-strategica di queste opere (e dei maestri) furono un punto di riferimento per tutta l’Europa ed ebbero un impatto profondo sull’evoluzione della scherma. Nostre principali fonti di riferimento sono:
- Anonimo Ravennate, circa 1520
- Antonio Manciolino, 1531 (1522-23)
- Achille Marozzo, 1536
- Marc'Antonio Pagano, 1553
- Giacomo di Grassi, 1570
Risultano di particolare interesse per il nostro campo di studi anche le opere di altri importanti maestri:
- Camillo Agrippa, 1553
- Francesco di Sandro Altoni, metà XVI secolo
- Giovanni dall'Agocchie (1572)
- Angelo Viggiani, 1575 (1551)